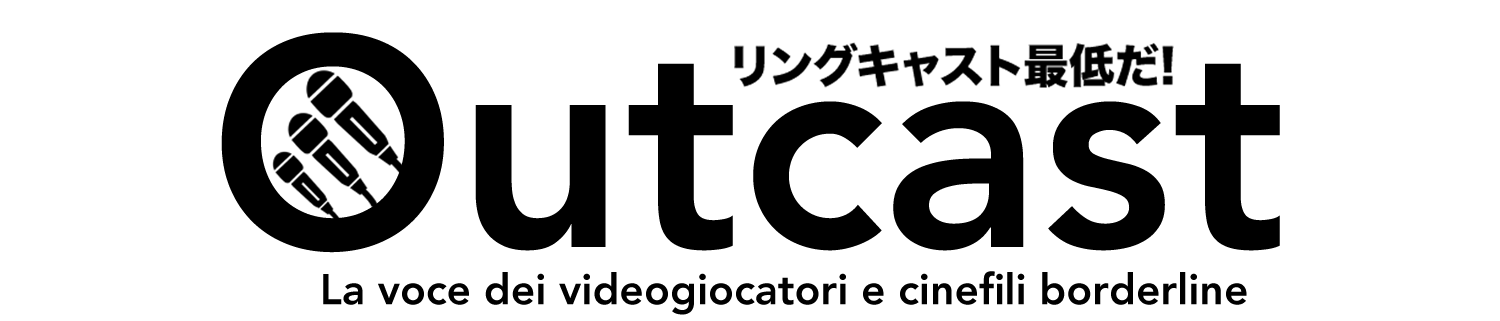Mecha Evolution: Dalle origini al vangelo della nuova genesi
Per tutta una generazione di italiani, che oggi ha un’età compresa tra i quaranta e i cinquant’anni, il pomeriggio televisivo dell’infanzia è stato segnato dalla presenza di robot giganti che lottavano per la salvezza del Giappone da una qualche minaccia ultraterrena. Anime disegnate che, quando era ora di spegnere la TV, prendevano la forma di giocattoli di plastica e, tra magli perforanti a molla e raggi gamma onomatopeici, continuavano a combattere in salotti e camerette. Eh sì, perché quando si parla di mecha design, è proprio da lì che bisogna partire, da una modalità di progettazione che deve tenere conto di due esigenze: la facilità di riproduzione televisiva da una parte e l’ingegnerizzazione del giocattolo dall’altra.
Il termine “mecha” nasce in Giappone come abbreviazione dell’inglese “mechanical”, preso in prestito e storpiato in “mekanikaru”, per riferirsi, in generale, a oggetti meccanici come auto, pistole, computer e altri dispositivi. Tra questi dispositivi, rientrano anche i robot giganti dalle forme umanoidi, pilotati direttamente da una cabina posta nella testa o nel petto: il mecha design per antonomasia.
Dal boiler all’automobile bipede
In realtà, la storia del genere robotico comincia con un androide dalle proporzioni umane, Astro Boy (Testuwan Atom) di Osamu Tezuka, nel 1952. Ibrido tra Pinocchio e il mostro di Frankenstein riletti in chiave sci-fi, Astro Boy difficilmente rientra nella categoria mecha secondo gli standard odierni ma è innegabile come il suo design (in qualche modo ispirato ai personaggi Disney) abbia influenzato i fratelli maggiori (nelle dimensioni), a cominciare da Tetsujin 28, manga illustrato da Mitsuteru Yokoyama nel 1956, in cui compare per la prima volta un robot gigante, controllato a distanza da un ragazzino.
Le forme sono umanoidi ma ricordano quelle di un’enorme caldaia, con braccia e gambe flessibili come un tubo di scarico fumi e per testa un comignolo appuntito. Il salto di immaginazione successivo è compiuto da Go Nagai, che passa dalla stufa all’automobile con Mazinger Z nel 1972. Gli occhi del robot sono fanali e la maschera che copre l’ipotetica bocca sembra quella di un radiatore. Lo stesso autore dichiarò di essersi sì ispirato ad Atom di Tezuka e Testujin 28 di Yokoyama , tuttavia, volendo dare un tocco di originalità rispetto agli illustri predecessori, ebbe l'idea di far pilotare il mecha dall’interno proprio mentre si trovava in un ingorgo, immaginandosi la piacevole sensazione di poter aggirare tutto quel traffico alzandosi semplicemente sulle gambe.
Nella fiction, il robot è progettato dal Prof. Juzo Kabuto, inventore di una nuova lega metallica chiamata “chogokin”. Termine che Bandai prenderà in prestito nel 1997 per dare vita ad una fra le linee di modelli più amate dai collezionisti di mecha: Soul of Chogokin, che esordirà proprio con Mazinger Z per poi passare in rassegna tutti i super robot più famosi, fino al recente Gipsy Danger di Pacific Rim - chiaro omaggio dell’occidente all’epoca d’oro dei mecha giapponesi. E, per quanto sia forte la tentazione di chiudere il cerchio con le creature di Guillermo del Toro, il viaggio è ancora lungo.
Il successo planetario di Mazinger Z spinge Go Nagai a dare vita a un vero e proprio universo di Super Robot, alla stregua del Marvel Cinematic Universe. Dopo Mazinger Z è la volta del Great Mazinger, poi di Grendizer, che esce da un disco volante venuto dallo spazio, e di Getter Robot, che può avere tre forme differenti a seconda dell’ordine con cui si combinano le tre astronavi che lo compongono. La continuity dell’universo naganiano si perde in Italia, dove il primo ad arrivare, importato dalla Francia, è Goldrake (il Grendizer giapponese), nella serie Atlas Ufo Robot (nome nato da una divertente incomprensione), che segnerà appunto l’immaginario collettivo di quella generazione di italiani di cui si diceva poco sopra, a scapito della fedele corrispondenza con l’originale.
Come la luna e il sole
Nel 1975, il prolifico Go Nagai, per conto di un altro produttore, dà vita a una nuova creatura, chiamata a combattere contro l’antico popolo di Yamatai che, risvegliatosi da un sonno millenario, vuole riconquistare la Terra. A differenza dei modelli ispirati a sobrie automobili, il nuovo paladino dell’umanità ha i colori sgargianti come la divisa di una guardia svizzera e, soprattutto, è composto da tante parti intercambiabili, tenute insieme dalla forza magnetica. È Jeeg, robot d’acciaio, altro pilastro dell’intrattenimento televisivo dei giovani italiani dei primi anni Ottanta, che offrirà lo spunto per una linea di giocattoli magnetici di grande successo, i Micronauti.
In questo decennio, i super robot vivono un’epoca d’oro, dando vita, tra gli altri, a design iconici come Zambot 3 e Daitarn 3, entrambi prodotti da Sunrise nella seconda metà degli anni Settanta e opera del dinamico duo Yoshiyuki Tomino (storie) e Kunio Okawara (mecha design).
Dal punto di vista della fiction, Zambot e Daitarn sono due serie diverse quanto la notte e il giorno: drammatico e legato al tema della luna il primo, irriverente e scanzonato il secondo, incentrato sulla forza del sole (“Attacco Solare! Energia!”). Sebbene Daitarn 3 nasca proprio dalla voglia di Tomino di cambiare registro, il progetto in realtà ha origine prima di Zambot, ma il fallimento dello sponsor, l’azienda di giocattoli Bullmark, ne blocca la realizzazione. Questo a testimonianza del rapporto diretto tra mecha design e messa in onda: tutte le serie TV, infatti, sono prodotte grazie ai soldi degli sponsor che, nel caso degli anime a tema robotico, sono per lo più aziende di giocattoli, che finanziano o commissionano direttamente un determinato tipo di fiction per poterne venderne i modelli (vedi il caso emblematico dei Transformers).
Ma perché soffermarsi sulle opere di Tomino e Okawara? Perché alla fine degli anni Settanta rivoluzioneranno il settore dei mecha, introducendo il concetto di “real robot” con la serie Mobile Suit Gundam (1979), dicendo addio alle entità indistruttibili e semi-divine naganiane ( “Ma-” significa “demone” e “-Jin”, “dio”) per lasciare il posto a robot da combattimento trattati come semplici veicoli militari.
Mentre il concetto di super robot, così come pensato da Go Nagai, grazie a Takara prenderà la deriva dei Transformers, vere auto che si trasformano in robot coscienti e dotati di volontà propria (non pilotati da esseri umani), Tomino e Okawara cercano di rendere più plausibile l’esistenza di questi colossi d’acciaio trasformandoli in carri armati antropomorfi, complicati da pilotare, con munizioni scarse, passibili di malfunzionamenti e distruzioni e controllati da fragili personaggi umani che non sempre hanno la stoffa dell’eroe.
Questo non è un giocattolo
Se l’evoluzione tecnologica permette la realizzazione delle complesse trasformazioni degli Autobot in perfette riproduzioni di auto reali, trasformando ben presto i giocattoli di Takara nell’oggetto del desiderio dei bambini di tutto il mondo, vendere i modellini di Gundam è più difficile. Complice anche una fiction virata al drammatico (non è un segreto che Tomino soffrisse di depressione), la serie di Gundam stenta a decollare. Fu un’altra azienda produttrice di giocattoli, Bandai, a salvare il futuro dei mobile suit con una rivoluzionaria serie di modelli assemblabili, i Gunpla. Il termine, nato dalla contrazione di “Gundam plastic model”, designa una linea di modellini in plastica contraddistinti da un elevato dettaglio e dalla possibilità di personalizzazione. Soprattutto, non serve più colla per tenere insieme i pezzi, che possono essere semplicemente staccati dagli stampi e incastrati e, dimenticandosi delle istruzioni, è possibile dare vita a modelli originali. Con i Gunpla, Bandai riuscì a raggiungere un nuovo bacino di utenza, rappresentato dagli appassionati di modellismo militare, composto da un pubblico più adulto rispetto ai giocattoli tradizionali, che conquistò grazie alla massiccia pubblicità su importanti testate di settore come Hobby Japan.
Il successo fu incredibilmente rapido, merito di un'ampia gamma di scale e livelli di complessità nell’assemblaggio, e grazie a continue innovazioni e miglioramenti nelle articolazioni, nei colori e nelle trasformazioni disponibili. Tale evoluzione nella tecnica di stampa della plastica avrà un riscontro immediato nel design dei mobile suit televisivi, sempre più ricchi di dettagli e contorni frastagliati, completando così il passaggio dallo stile “dorico” naganiano al “corinzio” che contraddistinguerà le produzioni televisive dagli anni Novanta in poi (come The King of Braves GaoGaiGar, mai arrivato in Italia).
La musica per far danzare le Valkyrie
Se Kunio Okawara fu il primo “mecha designer” riconosciuto come tale, Shoji Kawamori lo seguì a stretto giro, lanciato dal successo planetario di Macross (1982). In qualità di autore del soggetto e del mecha design, Kawamori riuscì a coniugare la nuova tendenza del real robot con il filone classico delle grandi navi spaziali, riprendendo in modo originale la via già tracciata da Okawara con Mobile Suit Gundam. In un’unica opera, Kawamori riesce a combinare il melodramma con caccia stellari che si trasformano in robot, le Valkyrie (la seconda stagione fu prodotta grazie alle straordinarie vendite dei modellini) che danno vita a battaglie apocalittiche combattute mediante l'uso di mezzi non convenzionali come la musica (uno dei personaggi femminili principali, Lynn Minmay, è stata una delle prime idol animate, lanciando la carriera musicale di Mari Iijima, sua doppiatrice originale).
Sempre in ambito real robot ma in un contesto ancor più quotidiano è la serie di Patlabor (1988) di Masami Yuki che, al contrario di tutte le opere robotiche che l’hanno preceduta, non si focalizza tanto sui combattimenti quanto sugli eventi di contorno, soffermandosi sul vissuto dei protagonisti, piloti di mezzi meccanici usati in ambito civile. Il mecha design mostra infatti i “labor” come macchine bipedi impiegate per svolgere mansioni pubbliche, come costruzioni o pattugliamento: veicoli e utensili, il cui antropomorfismo è molto più iconico rispetto al passato. Solo Noa Izumi, la protagonista, ha dato un nome al suo Labor, Alphonse, lo stesso usato in precedenza per i suoi animali domestici.
Grazie alla regia di Mamoru Oshii, l’anime riscuote grande successo, ma Patlabor sembra essere la mosca bianca in un settore che non ha interesse a cambiare. Mentre il filone dei real robot punta ad un realismo sempre più esasperato (basti pensare ai decal che decorano i pannelli dei mobile suit, che ricordano le istruzioni dei macchinari industriali), gli autori di super robot si ingegnano in combinazioni e trasformazioni sempre più fantasiose e complesse.
Se inizialmente le trasformazioni sono fusioni coreografate pensate per essere spettacolari e ripetute ad nauseam (come nel caso di Getter Robot, Daltanious, Trider G7 e compagnia), successivamente diventano più logiche e tecniche, fino ad arrivare ai Transformers: l’animazione della trasformazione televisiva è ben più fluida delle intricate contorsioni del giocattolo, ma quel pezzo di plastica snodato permette di replicare con una certa fedeltà le gesta dei beniamini dello schermo.
Complice anche la computer grafica, che comincia a fare la sua ascesa nel mondo dell’animazione seriale, il mecha design degli anni Novanta è caratterizzato da linee più scolpite e meno morbide, ma da uno stesso modello tridimensionale è possibile ricavare lo stampo per il giocattolo e avere un riferimento preciso per le inquadrature su schermo.
La nuova genesi
Anche se il genere non ha più la stessa presa in occidente che aveva negli anni Settanta e Ottanta, in patria gode di estrema popolarità. Molte serie del passato vengono riprese in forma di remake, aggiornando storie e design per un pubblico più giovane ma continuando a strizzare l’occhio ai vecchi supporter. L’evoluzione del mecha design sembra così andare lungo una traiettoria prevedibile, con l’introduzione progressiva di elementi organici che cominciano a stemperare le rigide linee spezzate dei modelli precedenti. Poi arriva Neon Genesis Evangelion e tutto cambia.
L’intenzione del regista Hideaki Anno è proprio quella di rompere lo schema preconfezionato degli anime mecha, creando una serie innovativa, in netta antitesi con i canoni del genere. Il design degli Eva fu concepito e curato dal mecha designer Ikuto Yamashita e dallo stesso Anno, che si ispirò agli oni, i demoni del folklore giapponese, per conferire alle macchine una natura demoniaca: giganti a malapena controllabili da un essere umano. Fin dalla consegna delle tavole preparatorie, i disegni di Yamashita suscitarono così tanto scalpore da dividere anche i membri dello staff della casa di produzione, causando numerosi problemi allo studio Gainax. Le aziende di giocattoli dissero che robot simili non avrebbero mai potuto vendere, soprattutto a causa degli arti inferiori, ritenuti troppo sottili e incapaci di reggere la struttura. Il dado ormai era tratto: per evitare qualsiasi interferenza da parte degli sponsor, Anno progettò dei robot volutamente difficili da riprodurre in giocattolo, in modo da avere la libertà artistica necessaria a rivoluzionare il genere. Dentro Evangelion mise tutto se stesso e lo sforzo fu ripagato da un successo planetario senza precedenti, che mise d’accordo oriente e occidente, critica e pubblico, ridefinendo non solo i canoni del mecha design ma la percezione degli anime come forma espressiva.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata all’arrivo di Neon Genesis Evangelion su Netflix e ai robottoni in generale, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.