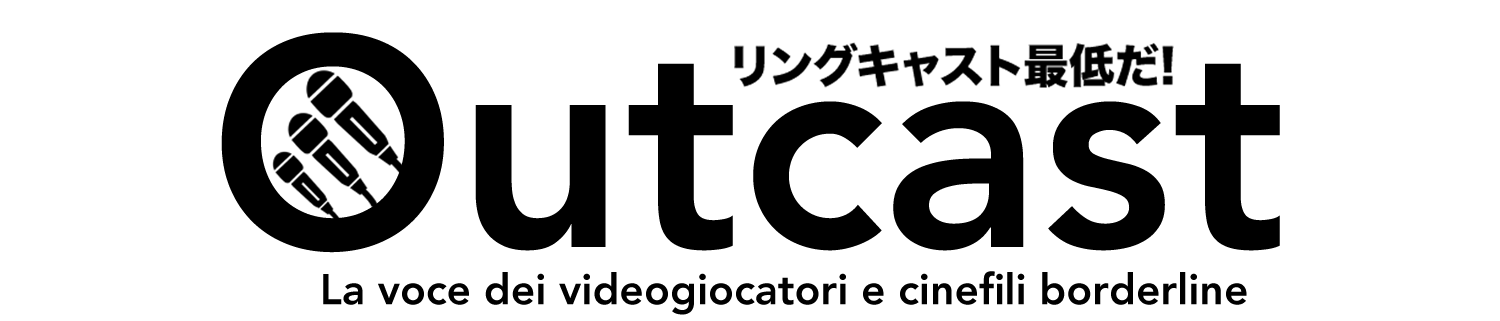Spazio Labirinto
Disegnare un labirinto è un esercizio che dovrebbero compiere tutti, almeno una volta.
È un’azione che dice molto di sé stessi. Da cosa si parte? Dal centro? Dai lati? Dalla forma? Dall’esterno verso l’interno? Dall’interno verso l’esterno? Quadrato, circolare, solitamente rettangolare, per la possibilità di concentricità dei percorsi.
Come lo pensate, mentre lo disegnate? Dall’alto? Dal di dentro?
Per chi è, questo labirinto? Quale è il suo scopo? Per tenere qualcuno dentro? Per tenere qualcuno fuori?
È una prova? Un percorso?
SIGLA
Partiamo dal presupposto che all’origine del termine labirinto c’è un fraintendimento culturale. Il mito del Minotauro, il rampollo deforme ed erede della civiltà Minoica, precorritrice di quella Greca, affonda le radici in una verità storica. Tutta la simbologia classica deriva da lì: un toro perché il toro era il simbolo del Re di Cnosso; il labirinto come sede del re, una sorta di città-palazzo fortificata dalla pianta difficilmente decifrabile, con svariati ambienti distribuiti come stanze e un grande cortile centrale ad uso di piazza.
La tesi più solida, anche linguisticamente parlando, che vuole il termine scomposto nella radice labrys, termine greco per l’ascia bipenne, altro simbolo del potere minoico, con l’aggiunta della desinenza -into ad indicare il luogo.
Ovviamente, la mitologia e il significato simbolico arrivano molto prima dell’archeologia, che scopre le rovine sull’isola di Creta nel 1900.
La tradizione tramanda così quella che è l’idea del labirinto, spargendola in giro per il Mediterraneo, nella sua accezione “unicursale”, con una sola entrata e una sola uscita, diventando il simbolo di un “percorso tortuoso, accidentato, debilitante perché assolutamente il modo più complesso per unire due punti”, che da Platone arriva alla pavimentazione delle chiese medioevali, assimilate a simbolo del percorso della fede con al centro Dio.
Sul pavimento della cattedrale di Chartres.
Nella cultura occidentale, non c’è mai stata nessuna finalità pratica nella progettazione di un labirinto, non fino a che nell’ambito domestico di chi poteva permetterselo è entrato il pittoresco. È in queste circostanze che nacque il gusto ludico per il labirinto, il gusto di perdersi in un ambiente piacevolmente disordinato ma comunque controllato, sicuro.
Un vezzo per i quali diventeranno famosi prima i giardini all’italiana rinascimentali e poi i giardini alla francese.
Il pittoresco.
Sono qui poste le basi del concetto di labirinto che accompagna come divertissement un certo gusto del level design: nessuno sviluppatore (come del resto nessuno progettista reale) vuole veramente imprigionare chi percorre il proprio labirinto.
Per quanto complessi, i labirinti hanno sempre una soluzione anche nella banale circostanza di avere dimensioni fisiche finite e caratteristiche che ti permettono di arrivare alla fine del percorso.
Un gioco vuole essere risolto.
Da Pac-Man e i suoi labirinti piani a quelli estrusi di Doom, fino agli ambienti peggio incasinati di Bloodborne, i labirinti non sono pensati come prigioni ma progettati per essere risolti. Semmai, a rendere la risoluzione più astrusa e complessa c’è la condizione psicologica in cui il labirinto mette il giocatore, la sensazione di smarrimento che si può provare indipendentemente dalla dichiarata natura labirintica dell’ambiente.
In questo ambito, il film definitivo sul labirinto è Inception di Christopher Nolan. Quello che viene chiesto ai progettisti del sogno è costruire un ambiente per intrappolare la mente di una persona, senza che questa si renda conto di essere intrappolata. Un labirinto che segue correttamente la logica onirica per la quale, nel momento in cui sei consapevole di star sognando, ti svegli e quindi sfuggi al labirinto.
Nei labirinti la logica è simile, perché nel momento in cui ti rendi conto di essere in un labirinto, inizi a cercare la via d’uscita e, se via d’uscita c’è (e dovrebbe, perché altrimenti non sarebbe un labirinto), si ha una possibilità diversa da 0 di trovarla.
La situazione cambia radicalmente nei domini della mente, dell’inconscio, dove il concetto di labirinto assume connotazioni più sfumate.
Quando Borges racconta La casa di Asterione, aggiornando al realismo magico tipico dello scrittore sudamericano il mito del minotauro, allude alla condizione di solitudine e alle difficoltà che provano gli individui nell’interfacciarsi con gli altri.
Nella raccolta de L’Aleph, troviamo una definizione di labirinto più materiale ed esplicita nel racconto L’immortale. Con una narrazione che per certi versi richiama il topos lovecraftiano del viaggiatore, la cui sete di conoscenza lo spinge in luoghi fisici e metaforici lontani, il viaggiatore di Borges arriva dopo un lungo viaggio ad una città intellegibile per la sua mente, antica come il tempo stesso, nella quale non riscontra alcuna logica costruttiva a lui nota.
“All’impressione di enorme vetustà altre si aggiunsero: quella dell’interminabile, quella dell’atroce, quella d’una complessità insensata. Avevo percorso un labirinto, ma la nitida città degli immortali m’impaurì e mi ripugnò.
Un labirinto è un edificio costruito per confondere gli uomini; la sia architettura, ricca di simmetrie, è subordinata a tale fine. Nel palazzo che imperfettamente esplorai l’architettura mancava d’ogni fine. Abbondavano il corridoio senza sbocco, l’alta finestra irraggiungibile, la fastosa porta che sia priva su una cella o su un pozzo, le incredibili scale rovesciate, coi gradini e la balaustra all’ingiù.”
Per essere un labirinto, deve esserci uno strappo netto tra progettista, per il quale la sua creatura è logica, e il fruitore, colui che lo attraversa, che ignorandone la logica, si sente irrimediabilmente perso. Un labirinto slegato dalla forma di labirinto.
Vale ulteriormente la pena di ricordare nella narrativa più vicina a noi Eco e Il nome della rosa.
Il famoso labirinto della biblioteca nascosto ai più, il cui segreto per decifrarlo viene tramandato di bibliotecario in bibliotecario: l’ordine geografico del mondo riportato nella logica distributiva delle varie sezioni della biblioteca, in un’operazione che definirei di architettura para-alchemica, di riproduzione dell’ordine attraverso l’apparentemente disordinata natura delle cose mondane.
Anche qui è un percorso, non lineare e non unidirezionale, al cui termine c’è una più completa visione delle cose, la conoscenza, l’illuminazione.
Che la fa pure Battiato, ma Milva la trovo più sferzante.
Quando si poteva ancora viaggiare, mi è capitato di imbattermi in labirinti. Non so quanto questi lo fossero volutamente, la questione è legata ancora una volta al senso di spaesamento, quello certamente voluto, e la volontà di porre il visitatore davanti a un percorso.
Ancora curiosamente, erano situati entrambi a Berlino, città che mi ha lasciato sensazioni contrastanti e alla quale difficilmente lego un ricordo piacevole, in piena controtendenza con molti miei colleghi che invece guardano alla Germania come terra delle opportunità e delle promesse, nemmeno fossimo nel pieno del boom migratorio degli anni Cinquanta.
Lindenstraße 9-14.
Il Jüdisches Museum Berlin (Museo ebraico di Berlino) è il museo ebraico più grande d’Europa, composto da due edifici, il Kolledinhaus (del 1735, ex corte di appello prussiana) e l’ampliamento del 1999 ad opera dell’architetto Daniel Libeskind.
È un museo atipico: la pianta non segue nessun criterio di funzionalità ma nasce dalla decostruzione di una Stella di David, con lo scopo di far “rivivere” attraverso un percorso la storia degli Ebrei in Germania. Tralasciando l’edificio storico, che conserva una fruizione più tradizionale, l’ampliamento pone il visitatore a vivere diverse fasi di atterrimento, attraverso installazioni dal grande impatto emotivo, tanto che all’epoca lo definii, forse in un eccesso di cinismo, il “parco a tema dell’olocausto”, dove i tedeschi vanno per sentirsi in colpa.
Foglie cadute.
L’installazione Shalechet dell’artista israeliano Meneshe Kadishman è composta da 10000 volti in acciaio distribuiti sul pavimento di uno spazio vuoto, dedicato alla memoria. Dedicato a tutte le vittime della violenza della guerra.
Il visitatore è invitato a camminarci sopra per ascoltare il rumore, amplificato dal vuoto, che fanno i propri passi sui volti d’acciaio.
Similmente, la Torre dell’olocausto è un altro spazio vuoto verticale, non ventilato, completamente buio e dipinto di nero, al quale si accede attraverso una porta molto spessa e pesante, posta al termine dell’”asse della morte”. Una volta entrati, il buio è soverchiante, diventa impossibile vedere le altre persone e distinguerne i connotati.
L’unica luce arriva da una fessura posta in alto, dalla quale è impossibile guardare fuori.
Lo scopo simbolico è voler restituire la sensazione che dovettero provare gli ebrei deportati.
E le sensazioni provate sono effettivamente forti, passando cinque minuti chiusi lì dentro.
Come tutti i labirinti, anche questo culmina in uno spazio aperto, epilogo della storia degli ebrei in Europa.
Al termine dell’Asse dell’esilio, c’è un Giardino, una superficie quadrata circondata da quarantanove colonne di cemento alte sei metri, in modo che dall’esterno non si possa vedere nulla.
Il significato simbolico è nelle 49 colonne, 48 come l’anno di nascita dello stato di Istraele +1 che rappresenta Berlino.
Su ogni colonna è piantato un albero di olivagno come simbolo di pace, speranza e resistenza alle avversità.
Il memoriale dell’olocausto è una tappa fondamentale della “vacanza che si rispetti a Berlino” (TM). Se non ci siete stati, lo avete visto almeno una volta sul profilo Instagram di uno dei vostri follow. È molto divertente che uno dei monumenti più drammatici della città sia diventato anche uno di quelli più instagrammabili.
Opera dell’architetto Peter Eisenman, edificato nell’area originariamente occupata dal Palazzo di Goebbels nel quartiere Mitte di Berlino, ad un tiro di schioppo dall’Isola dei musei, occupa tutti i 19000mq dell’isolato, con 2711 steli di calcestruzzo scuro organizzate in griglia ortogonale, totalmente percorribile.
Dall’esterno, le steli sembrano tutte più o meno di altezza simile ma in realtà variano al variare della irregolare quota di calpestio.
Chi si approccia incamminandosi al suo interno perde progressivamente il senso dell’orientamento, in uno spazio che diventa come un canyon di lastre marmo, anonimo, con i punti di riferimento ridotti al minimo, intercettando inevitabilmente il percorso degli altri visitatori, che spuntano da ogni angolo.
Qui il labirinto si manifesta nella completa arbitrarietà del percorso e della direzione da prendere.l Non c’è traiettoria da seguire, nessun inizio e nessuna fine, solo la sensazione di smarrimento, in uno spazio che è aperto e opprimente allo stesso tempo, contesto evidenziato nelle giornate di bel tempo dallo stacco netto tra il grigio del calcestruzzo e la sfrontatezza del cielo azzurro.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata all’escapismo, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.