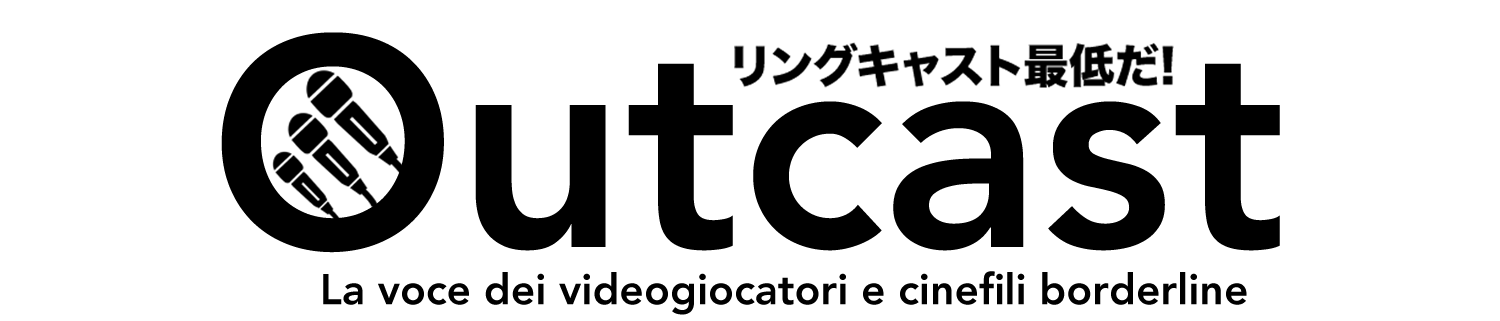Racconti dall'ospizio #203: Resident Evil, Un incubo lungo più di vent’anni
Racconti dall’ospizio è una rubrica in cui raccontiamo i giochi del passato con lo sguardo del presente. Lo sguardo di noi vecchietti.
Ti trovi nell’atrio di una gigantesca villa in stile vittoriano. Di fronte si erge un’ampia scalinata, ai lati una serie di porte chiuse. L’atrio è vuoto e silenzioso, ma attraverso quelle pareti senti palpitare la presenza del male. Non sai cosa possa nascondersi dietro quelle porte sbarrate ma speri solo che, qualunque cosa sia, non riesca ad aprirle. Il sudore comincia a formarsi in perle sulla fronte, l’adrenalina viene messa in circolo e il cuore comincia a battere più velocemente. Controlli la tua Beretta: quindici colpi nel caricatore. Ti giri verso la porta a destra e il sordo rimbombo dei passi innesca un brivido lungo la colonna vertebrale. Giri la maniglia della porta e la vedi spalancarsi nel buio, mentre il flusso dei dati si carica sullo schermo per ricomporre una nuova immagine. Sei nella stanza e, prima ancora di percepirne la struttura, sobbalzi al rumore di una finestra che vola in frantumi. Un’ombra nera piomba dentro e con un salto ti è addosso…
È il 1996: Braveheart ha vinto l’Oscar come migliore film, il teatro la Fenice di Venezia è ridotto a un cumulo di cenere, ma tu sei già due anni nel futuro, per la precisione a Raccoon City, una cittadina sperduta nel cuore degli USA, dove il pericoloso agente patogeno, noto come T-virus, ha cominciato a mietere le prime vittime.
“Benvenuto al survival horror.”
Sarebbe ingiusto nei confronti di chi è venuto prima (Alone in the Dark, Beyond the Forbidden Forest… ) dire che Resident Evil sia il capostipite di un genere. Tuttavia, è proprio da Resident Evil in poi che il survival horror è diventato un genere. Un po’ come i Soulslike oggi, per intenderci. L’idea di creare un titolo horror venne in realtà non tanto da Shinji Mikami, lead designer, ma da Tokuro Fujiwara (autore di pietre miliari come Ghosts ‘n Goblins e padre della saga di Mega Man, la mascotte di Capcom), suo superiore e mentore, che gli raccomandò espressamente di prendere come riferimento un “vecchio” gioco di ruolo chiamato Sweet Home. Realizzato per il Famicom nel 1989, il gioco Capcom, misconosciuto in occidente, è la trasposizione videoludica del film omonimo, uscito nelle sale cinematografiche del Sol Levante proprio lo stesso anno. La vicenda ruota attorno a una squadra speciale, inviata a investigare sull’improvvisa scomparsa del pittore Mamiya Ichirou. Intrappolati in una misteriosa villa nel cuore della foresta, i cinque protagonisti potranno uscirne vivi solo risolvendo il complesso enigma celato negli affreschi del pittore. Mentre si dipana la vicenda, il fantasma della moglie di Mamiya comincia a perseguitare gli investigatori dell’occulto. Esplorando varie sezioni della casa, i protagonisti fanno numerosi incontri con creature soprannaturali e, insieme ai cadaveri della squadra investigativa precedentemente inviata sul posto, incrociano i loro destini con l’inquietante Yamamura (il pittore stesso?), che li aiuta a ricucire i pezzi che compongono l’intricato mistero. L’orrore di Sweet Home è narrato attraverso stralci di giornale, appunti e scritte sui muri lasciate dai precedenti esploratori che, oltre a fornire indizi sulla risoluzione degli enigmi, contribuiscono ad accrescere la suspense, accentuata da improvvise sequenze d’azione in prima persona durante le fasi di esplorazione.
Anche dal punto di vista formale, Sweet Home si rivela fondamentale nella creazione dell’immaginario di Resident Evil, adottando precise scelte stilistiche, come l’animazione, vista in soggettiva, di una porta che si apre per introdurre i personaggi in una nuova stanza – una scelta grafica in aperto contrasto con la visuale principale di gioco a volo d’uccello, che richiama quella dei combattimenti, dove il mostro viene sbattuto direttamente di fronte al giocatore, con l’unica intermediazione di un menu a tendina. È lo stesso Mikami a citare apertamente Sweet Home: «All’inizio, lo scopo era fare in modo che il giocatore avesse paura di aprire la porta senza che questa sequenza venisse mostrata. Tuttavia, i dati della stanza sono così pesanti che, quando la PlayStation li sta caricando, lo schermo diventa nero. Pensavo a come ovviare al problema e mi ricordai di come veniva affrontato in Sweet Home. Mi resi conto che la sequenza di apertura della porta avrebbe accresciuto la tensione nel giocatore.»
Partendo quindi da Sweet Home come riferimento, non stupisce più di tanto la scelta di ambientare il gioco in una villa di stile gotico, densa di atmosfere tenebrose. La vicenda è in un primo tempo assolutamente accessoria: «In origine, Resident Evil si basava solamente su tre stanze: l’ingresso, la sala da pranzo e il bar. L’idea era di avere degli eroi che andassero in giro a uccidere zombie. Partendo da questi elementi, ho realizzato un intero mondo, aggiungendo tutti i dettagli che avrebbero creato la giusta atmosfera. Grafica, trama e personaggi furono tutti subordinati all’effetto che volevo suscitare nel giocatore». Mikami dice di non aver mai scritto una riga di sceneggiatura, ma solo note e diagrammi di flusso. Il concept di gioco è rivolto a sviscerare un nuovo tipo di divertimento: quello che può derivare dalla paura suscitata da un ambiente assolutamente familiare, come casa propria. Quando la percezione inizia ad insinuare dei dubbi in ciò che crediamo di conoscere così intimamente, ecco che veniamo colti da una sorta di panico voluttuoso. «Una casa infestata non ha bisogno di una sceneggiatura o di una storia!», continua a ripetere imperterrito Mikami ai manager Capcom, cercando di giustificare le scelte di game design attuate. Ma le pressioni sono tali che, alla fine, l’autore deve arrendersi al volere dei superiori. Il tempo rimasto non è però sufficiente per creare una vicenda complessa e ri-organizzare il gioco di conseguenza.
Per capire quanto fu complicata la gestazione, e quanto furono confuse le idee, basta citare le parole di Hideki Kamiya, ai tempi membro di punta dello staff di Mikami: «Il nostro desiderio più grande era quello di esaminare il tema della paura, perché eravamo convinti che non fosse ancora stato scrutato a dovere. L’obiettivo era quello di sfruttare le capacità grafiche di PlayStation per suscitare nella maniera più realistica possibile tale senso di paura, che è parte integrante dell’istinto umano. Nelle prime fasi di sviluppo, il gioco presentava una prospettiva in prima persona come Doom; tuttavia, in quel modo non riuscimmo ad ottenere una resa grafica soddisfacente. E così decidemmo di cambiare lo stile di gioco; in questo modo, potevamo usare scenari renderizzati in computer grafica molto più realistici e, allo stesso tempo, avere personaggi composti da più poligoni. Fu così che venne implementato lo stile in terza persona.»
La scelta di popolare la villa di zombi nasce dalla semplice intuizione che chiunque si fosse messo a fare un gioco su una casa infestata sarebbe ricorso agli spettri. Tuttavia, rispetto al fantasma, lo zombi ha una presenza scenica molto più “consistente”: in preda alla propria insaziabile fame, lo zombi si scaglia contro il giocatore e, indifferente ai proiettili, crolla al suolo senza deviare dal tragitto verso la gola del protagonista. Soprattutto, questo incedere è facile da implementare a livello di intelligenza artificiale… «Non potevamo però creare un gioco basato unicamente sul combattimento con gli zombi», sottolinea Mikami. «Allo stesso tempo, non potevamo nemmeno creare un gioco in cui ci si limita a camminare senza che non succeda altro. Così decisi di inserire un po’ di mistero e diversi rompicapi, per confondere il giocatore e fargli provare un senso di paura ancora maggiore.» L’idea forte alla base del modello di game design è quella di offrire tensione e rilassamento nella stessa quantità. Nel momento in cui un cadavere ambulante si avvicina al giocatore, questo sente insorgere, insieme alla paura e al disgusto suscitati dal mostro, il panico di non avere abbastanza proiettili; tuttavia, quando lo zombi giace a terra, messo fuori combattimento da tre colpi di Beretta, il giocatore può rilassarsi e procedere nell’esplorazione della villa.
Una delle decisioni più dibattute, poi, riguarda il punto da cui far cominciare l’esplorazione. Alla fine viene scelta l’opzione “sparo nella hall” e il protagonista viene mandato a investigare. Mikami stesso dichiara che si tratta di un espediente piuttosto ingenuo ma, al momento della decisione, nessuno se ne era venuto fuori con un’idea migliore. E questo fa capire come la creatività, per il team di Mikami, fosse essenzialmente parte di un processo di riduzione. L’obiettivo, durante le fasi di sviluppo, non era tanto quello di creare un gioco popolare, ma un titolo capace di suscitare fanatismo negli hardcore gamer: «Quando si crea un gioco, non bisogna nascondere i suoi punti deboli, ma fare in modo che il pubblico li ami ciecamente.» E i punti deboli di Resident Evil sono tutti lì, in bella vista. Fu proprio questo il motivo per cui il gioco conquistò subito il cuore dei fan.
Fra gli elementi che più colpirono la sensibilità dei gamer nel 1996, comunque, ci sono le sequenze di morte, le più realistiche e raccapriccianti raffigurate in un videogioco fino ad allora. Il protagonista può cadere dissanguato sotto gli attacchi degli zombi, divorato dalla loro insaziabile fame o, peggio ancora, decapitato dalla furia assassina dell’hunter. Nessuno aveva mai assistito prima di allora a sequenze di game over così varie e altrettanto dolorose. Tanto più se si considera che, al posto di un neutrale messaggio di fine partita, Resident Evil accentua il ruolo di coinvolgimento del giocatore con un inquietante “You Died” scritto nel sangue. Senza dimenticare l’ulteriore sofferenza imposta dalla necessità di riprendere la partita dall’ultimo punto di salvataggio utilizzato: operazione possibile solo in un numero ristretto di stanze munite di macchina da scrivere. Per poter impiegare la macchina da scrivere, però, è indispensabile la presenza di un nastro inchiostratore, ovviamente una fra le risorse più scarse nell’economia di gioco…
Già il fatto che le creature uccise non svaniscano subito (ma solo all’uscita da uno scenario) comporta di per sé uno shock notevole; in più, l’unico modo per avere la certezza di aver eliminato l’avversario è osservare il sangue che sgorga dal cadavere raccogliersi in una pozza – qualora ciò non accada, vuol dire che il mostro si rialzerà presto, pronto a combattere con rinnovato vigore.
Un ruolo importante viene infine svolto dal commento sonoro. Non ci sono musiche che accompagnano l’intera partita, ma solo sporadici inserti di tastiera, che servono a richiamare l’attenzione del giocatore. L’unica melodia è quella che contraddistingue le stanze dove è possibile salvare la partita. Altrimenti domina il silenzio, rotto dal rimbombo dei passi e dai grugniti delle creature nascoste dietro l’angolo. Dove la vista è impedita, l’unico modo che il giocatore ha per ottenere informazioni è affidarsi al senso dell’udito. Da sottolineare come, nella selezione delle opzioni all’interno dei menu, il suono corrispondente sia il ticchettio meccanico dei tasti premuti sulla macchina da scrivere. Anche i testi introduttivi compaiono su schermo lettera per lettera, come se il protagonista stesse redigendo la pagina di un verbale (azione più che plausibile, data la posizione di ufficiale di polizia).
Il titolo originale, Biohazard, che ancora contraddistingue la serie nel Sol Levante, è merito di un grafico degli scenari. Mikami avrebbe voluto usare un nome corto, qualcosa come “Psycho”, tuttavia il titolo “Biohazard” si rivela coerente con gli elementi che saranno incastrati a forza nella storia. La diversa nomenclatura occidentale deriva da problemi di copyright, in quanto si tratta di un nome già registrato da una band di heavy metal. Ma anche Resident Evil (letteralmente: “male intrinseco”) si dimostra un nome all’altezza, forse addirittura più evocativo dell’originale, associando la parola “male” al concetto di “residente”, nel senso di essere presente in maniera endemica, ma anche per assonanza con la parola “residenza”, che ha la stessa radice e che richiama la villa infestata dagli orrori mutanti della Umbrella Corporation.
Nel giro di un anno dalla pubblicazione, Resident Evil raggiunge l’intero pianeta. Oltre quattro milioni di copie vengono venduti solo su PlayStation. Capcom annuncia che il gioco ha generato profitti per oltre duecento milioni di dollari, rivelandosi il più grande successo nella storia della software house giapponese, addirittura maggiore rispetto al popolarissimo beat’em-up da sala giochi Street Fighter II.
La casa di produzione tedesca Constantin Film non perde l’occasione di accaparrarsi al volo i diritti (il film uscirà a sei anni di distanza, dopo una gestazione assai travagliata), segno che il fenomeno è pronto a valicare i confini dell’industria videoludica, lanciandosi alla scalata dell’immaginario popolare.
Nell’autunno del 1997, quando l’isteria per l’imminente seguito raggiunge l’acme, Capcom pubblica l’edizione “Director’s Cut” del gioco originale (quella a cui possiamo giocare sulla piccola PlayStation Classic), ripulita a livello grafico - sono impiegati i fondali più brillanti della versione per Sega Saturn e con inserite nuove inquadrature, fornita di due modalità di gioco (Beginner e Arrange - con una diversa disposizione degli oggetti e nemici più coriacei rispetto all’originale), arricchita nelle animazioni e nei vestiti dei personaggi, impreziosita da filmati inediti e dal ripristino di quelli tagliati dalla censura occidentale.
Il resto, come si usa dire in questi casi, è storia.
N.B. Gli stralci delle interviste sono stati ripresi da riviste dell’epoca, in particolare EDGE #56, e tradotti da me. Solo in tempi recenti, durante il tour promozionale per The Evil Within, Mikami ammetterà di aver scopiazzato da Alone in the Dark, il gioco creato da Frédérick Raynal e pubblicato da Infogrames nel 1992. Ma anche ai tempi (tempi in cui, ricordiamolo, Internet non era così sviluppata) la citazione/plagio sembrò palese, nonostante in Capcom facessero tutti spallucce.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata a PlayStation Classic e alla prima PlayStation, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.